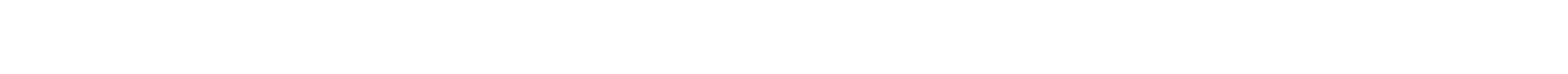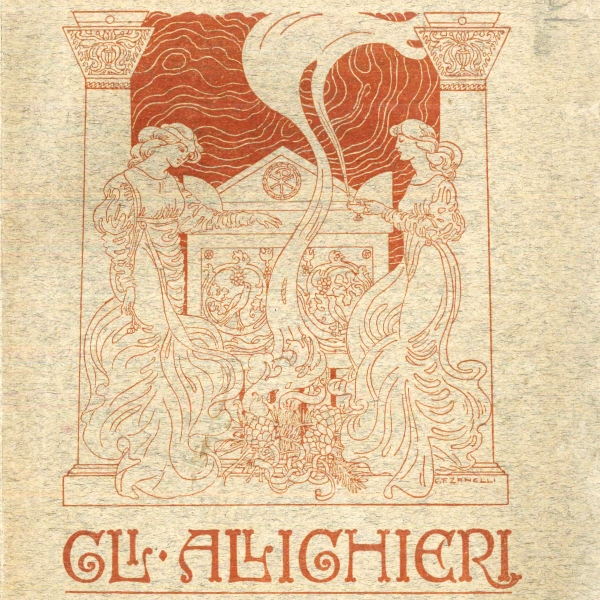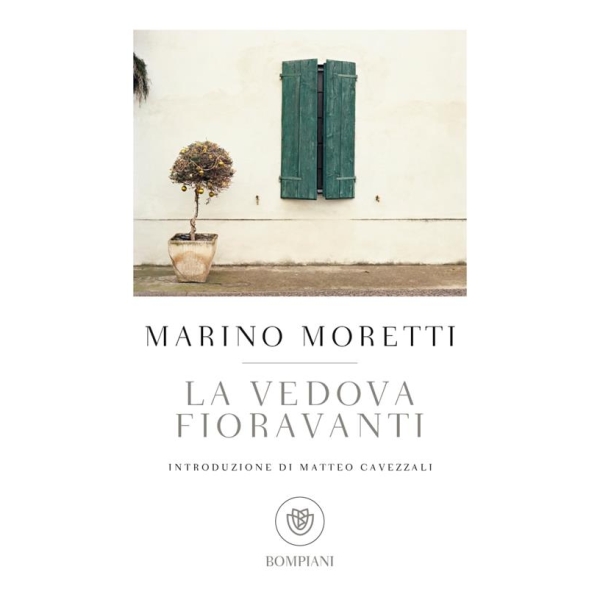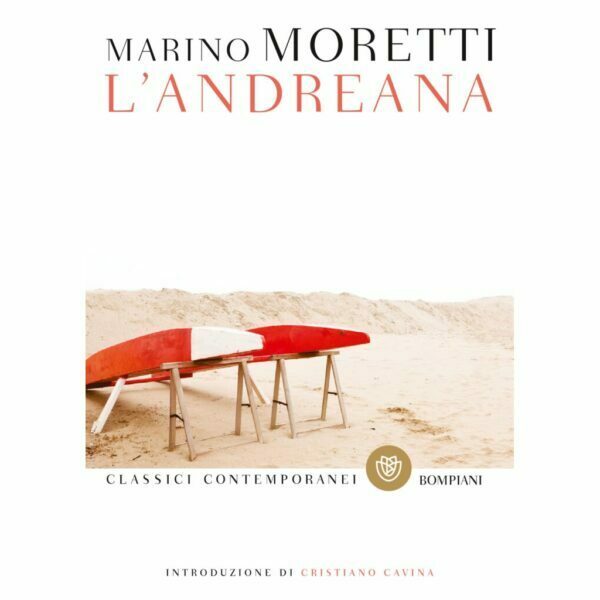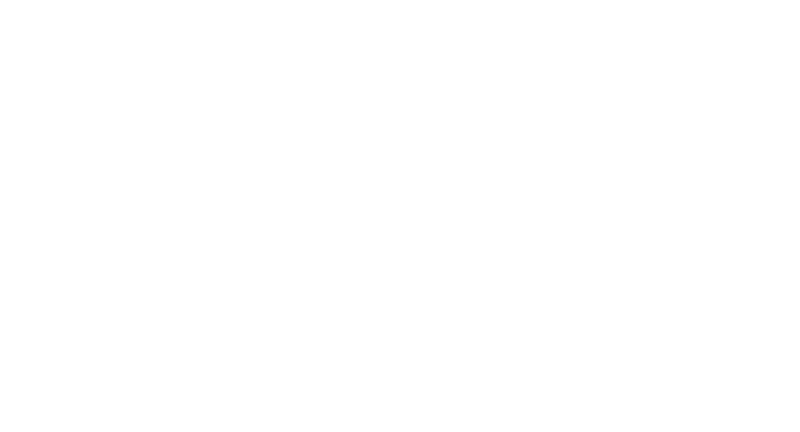La parola della poesia si confronta sempre con i bordi del silenzio, misurandosi ogni volta con i margini del non pronunciabile. Nel Novecento il confronto diviene traumatico: come parlare tra le catastrofi delle guerre mondiali e le distruzioni immani che ad esse si accompagnano, comportando sconvolgimenti sociali ed economici devastanti, e la crisi dei valori, la perdita del senso dell’umano? Il secolo breve assiste così, in pochi decenni, a mutamenti radicali che riguardano non solo i rapporti tra individuo e società, ma la concezione stessa del tempo e dello spazio e del rapporto tra soggetto e linguaggio, sottoposti a precarietà, frantumazione, velocizzazione, condizionamenti sempre più devastanti, come illustrano tra gli altri Bergson e Wittgenstein, Heidegger e Benjamin, Freud e Marcuse.
Ma teniamoci all’inizio. Ad aprire il secolo, in poesia, provvedono i crepuscolari, e con loro si apre anche questa mostra di Casa Moretti, che infatti ospita subito nella prima sala, a sinistra dell’ingresso, Govoni, Corazzini, Gozzano, Palazzeschi (Marino Moretti attende il visitatore nello studio al piano superiore). Poeti tutt’altro che ingenui e culturalmente sprovveduti questi crepuscolari, al contrario del cliché con cui li si è a lungo caratterizzati, bollandoli di sentimentalismo e provincialismo. Nella Torino di Gozzano o nella Ferrara di Govoni, nella Firenze di Palazzeschi e del cesenaticense Moretti, si leggevano in quegli anni Schopenhauer e Nietzsche, Weininger e i simbolisti francesi, i tardo- positivisti e i poeti franco-belgi, Valéry o Mallarmé e Apollinaire, ma anche Mach e le teorie einsteiniane della nuova scienza. Basterebbe solo volgere uno sguardo ai libri esposti negli scaffali della biblioteca di Moretti per verificarlo. Eppure “crepuscolari”, che andrebbero dunque perlomeno virgolettati, hanno avuto un destino curioso non solo nei manuali scolastici ma anche nella ricezione più diffusa, a causa di quell’appellativo, “crepuscolari”, appunto, che non si sono scelti da soli, ma di cui li ha insigniti il critico Borgese definendoli, in una recensione uscita sulla “Stampa” il 1° settembre 1910 dal titolo Poesia crepuscolare, “lirici che s’annoiano”, segnati dalla “torbida e limacciosa malinconia di non aver nulla da dire e da fare”, se non prendere “a gabbo le cose che prima si prendevano sul serio”. Da qui quella fama di poeti dalla vena flebile, che scelgono di piangersi addosso perché non hanno più nulla da dire, e con Gozzano si vergognano della poesia, con Govoni la ricoprono di “grigio” e di “silenzio”, con Corazzini la sciolgono in “lagrime da offrire al Silenzio”; ma poi con Palazzeschi la risolvono in divertissement, con Moretti in un “nulla da dire” carico di ironia. Già, perché al di là dei luoghi comuni che vanno sfatati, i poeti crepuscolari sono trasgressivi e iconoclasti, impegnati a ribaltare il sublime e la mitologia dei Poeti-Vati: quella di d’Annunzio, in primo luogo, con il vitalismo esasperato e il superomismo esibito. All’autoesaltazione del Meriggio di Alcyone (“e la mia vita è divina”) contrappongono il rifiuto, l’impotenza, la vergogna della poesia, con un ribaltamento che è per Palazzeschi il solo modo per opporsi alle “trombonate” dannunziane, ma è insieme il modo di prendere coscienza della fine del ruolo sociale del poeta in una società in rapidissima trasformazione, segnata dagli sviluppi della tecnica e dell’industria nonché dalle spinte imperialistiche e nazionalistiche che sfoceranno nei massacri della Prima Guerra Mondiale.
“Perché tu mi dici poeta?”- chiede Corazzini; e Palazzeschi aggiunge, da “saltimbanco” dell’anima: “gli uomini non domandano / più nulla / dai poeti: e lasciatemi divertire”. Sono la nostra avanguardia storica questi crepuscolari, alla pari dei futuristi, anche se più riservati e meno chiassosi, e anche alla pari dei “moralisti” della “Voce”: sono iconoclasti del sublime, scrivono con il lapis rinunciando alla penna d’oca, e non credono davvero più a una Poesia con la iniziale maiuscola, che all’interno della normalità borghese viene smascherata nella sua pronuncia, come viene smascherata l’enfatizzazione dell’io-poeta, che ha perduto l’aureola e viene esibito da Palazzeschi in Una casina di cristallo davanti alla “gente”, prigioniera a sua volta di conformismi borghesi e di luoghi comuni.
Parte così dai crepuscolari un grado zero della poesia che non solo piega la rima, ostentata al massimo grado per far cozzare, diceva Montale per Gozzano, l’aulico con il prosaico (“camicie” con “Nietzsche”, e però anche “malinconia” con “radioscopia”, “io” con “oblio”…), e per mettere in urto – aggiungeva Sanguineti – il sublime d’en bas con il sublime d’en haut, ma soprattutto porta la scrittura a confrontarsi con il vuoto di senso, sull’orlo di un grado zero dai connotati già molto moderni.
Se procediamo verso il tinello di Casa Moretti, ci rendiamo conto che è davvero difficile stipare in qualche riduttiva categoria la compresenza di direzioni che l’avvio del secolo propone. A mano a mano che la vita si fa amalgama, e già alla fine del primo decennio del secolo si scopre esposta a una “simultaneità intrecciata” di tendenze, come annota Boine, e a “raffiche di frammenti”, come scrive Boccioni, tra le menti più lucide del futurismo, mutano anche le prospettive del rapporto tra parola e silenzio. Con Rebora, Sbarbaro, Cardarelli, Saba, non si tratta più di vergogna della poesia: i versi acquistano piuttosto, con i Frammenti lirici (1913) del primo, i modi della torsione espressionistica, mentre la parola si contrae, sfiora l’afasia in versi duri, antimelodici, che registrano la colonna sonora del vivere metropolitano in una Milano esposta al “ferreo bàttito” dell’ora presente. Oppure, con Saba, il silenzio si confronta con le “trite parole” di una poesia “dimessa”, che tra ritmo e stilizzazione aspira a scovare una ragione vitale che risarcisca dai traumi, o con lo Sbarbaro di Pianissimo (1914) si misura con il suono che sempre più si attenua nella pronuncia in sordina, trattenuta e corrosa (“Così da me mi muro e pietre sono le parole”, si leggerà in Trucioli, 1920). Lungo questa via si può raggiungere il Montale degli Ossi di seppia (1925), la scansione del suo “balbo parlare”, che affida il proprio “ritmo stento” a una parola sterile come “storta sillaba e secca come un ramo”, nelle forme davvero nuove di un allegorismo moderno. Montale mette a frutto la prosasticità crepuscolare e gli effetti di abbassamento che essa comporta con la compostezza di una misura classica ritrovata tra stile e tradizione; ma poi è l’atonia, la coscienza del male di vivere, il trauma dell’insignificanza, a segnare il suo percorso, quello di una crisi esistenziale che si coniugherà, negli anni tragici della Seconda Guerra Mondiale, con la sospensione del senso (l’“anello che non tiene” nell’ordine di una natura che ha perduto il rapporto col divino), e con l’impossibilità di rinvenire formule salvifiche, risolutive. Meglio a quel punto la parola che tace, nell’incupirsi della storia e dei tempi, nell’“inferno certo” in cui si sta precipitando.
Con Montale si toccano i confini di un lirismo negato, di una poesia incline alla narratività, nel tempo senza speranza delle “monche esistenze”; ma si assiste anche all’assunzione della piena responsabilità etica della parola che denuncia i soprusi del totalitarismo, la retorica di fedi arroganti e cieche. Il poeta della “decenza quotidiana” non si vergogna davvero più della poesia, mentre prende atto dell’inadeguatezza della parola a dare voce al non essere, al non volere, al male di vivere. Non ama, Montale, la categoria dei lirici puri (tanto è sicuro, commentava parlando di ermetismo nel 1940, che “l’impurità, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra. Per fortuna!”): un cliché, anche questo, che nemmeno Ungaretti si sentirebbe del resto di condividere, lui che pure di quella linea è parso il capofila all’altezza di Sentimento del Tempo (1935). Ma Ungaretti resta soprattutto il poeta della torsione espressionistica, della essenzialità analogica, della parola scavata come “un abisso”, raggiunta sull’orlo dell’impossibilità di pronuncia e del silenzio, come scrive nel Porto Sepolto (1916), il diario di guerra che inaugura a tutti gli effetti la poesia del Novecento. In quel presente lacerato e ferito solo un’espressione spoglia, isolata nel verso, semanticamente intensa, poteva provare a stipare in frammenti l’angoscia dei massacri. Sarà però anche sempre cogente, in Ungaretti, il bisogno di confrontare la parola con il mistero della sua scaturigine, il porto sepolto, la zona buia del silenzio che ne preserva l’enigma, e da lì restituirla in scrittura mutila, scheggiata sino all’“urlo muto”, all’“angoscia frenata”, di chi sa che gli resta negato l’approdo alla Terra Promessa. Può stargli a fianco Cardarelli, anche lui esposto a una sproporzione tra precarietà e assoluto che si traduce, nel suo caso, in tensione tra ritrovata misura ritmica e sospendersi ansioso e assorto del verso, tra cose che trascolorano e parole afone. Neppure lui è in fondo lirico puro, mentre lo è invece il primo Quasimodo di Oboe sommerso (1932), che traccia silenzi alonati tra musicalità e vaghezza espressiva (“silenzio di cieli sepolti”), o il Gatto che, se raggiunge il silenzio, lo immerge in calda sensualità mediterranea. Ma soprattutto lo è Luzi, esponente storico dell’ermetismo fiorentino, la cui parola, attraversata da cicatrici, esprime il dissidio tra permanenza dell’eterno e smarrimento esistenziale, in un’inesausta “ricerca del profondo” che giungerà sempre più a sfiorare, negli esiti tardi degli anni Ottanta e Novanta segnati da versi ritmicamente e sintatticamente frantumati, i confini dell’afasia.
Abbiamo cambiato stanza, intanto, e con Luzi e Gatto troviamo esposti Caproni e Sereni. Diviene davvero difficile stabilire barriere tra questo provvisorio catalogo di modi e forme del non saper dire, del non voler dire, del non poter più dire, a mano a mano che ci si avvia verso la boa che separa il primo dal secondo Novecento. Può venire in soccorso Artaud, che introducendo Il Teatro e il suo doppio scriveva, nel 1938:“Se la caratteristica di quest’epoca è la confusione, vedo alla base di tale confusione una frattura fra le cose e le parole, fra le idee e i segni che le raffigurano”. Ottimo viatico per la parola di Caproni, che incide sul foglio tracce, graffiti di nomi, luoghi, vicende, tratteggiando un paesaggio di segni separati dalle cose, allegorie di presenze in lotta con la dissolvenza, Io smarrimento, la perdita (“Le parole. Già. / Dissolvono l’oggetto. // Come la nebbia gli alberi, / il fiume: il traghetto”). La sua poesia si colloca al di qua e al di là della boa del secolo, come quella di Sereni, disseminata di reticenze, “omissioni”, mancamenti, a un passo sempre dal “solido nulla”.
Ben poco separa questi poeti, la cui poesia raggiungerà gli anni ’80 del Novecento, da altri che troviamo salendo le scale che conducono al secondo piano: Franco Fortini, intanto, con la “severa elegia” di versi affidati a una pronuncia lapidaria, inaridita, tra “cemento e vetro”, e Giovanni Giudici che in Fortezza dà voce a un io murato insieme con la parola, e Alda Merini, anomala outsider della poesia, con il suo teso, ossimorico misticismo verbale. Diviene difficile proseguire un racconto di separazioni e raggruppamenti per l’età della crisi che segna per intero io spazio del secondo dopoguerra. Uno spazio di esilio dal confronto con la realtà e insieme di rinnovata consapevolezza della marginalità della poesia, bloccata nel tempo senza sviluppo che gravava già sull’Ungaretti del Dolore (“Il tempo è muto fra canneti immoti…”). Ad Artaud andrebbe allora accostata proprio la constatazione tragica di Ungaretti, affidata nel ‘66 a una riflessione sui mutamenti generati nella vita e nell’arte dal secondo conflitto mondiale: un “mondo apocalittico” è per lui il presente, in cui si vive “con la possibilità di autodistruggersi”, al punto che l’uomo “non riesce più a parlare”, perché – scrive – “c’è una violenza nelle cose che diventa la sua propria violenza”.
Osservando le bacheche del secondo piano ci si rende subito conto che la frattura di cui parlava Artaud tra nome e cose, e dunque anche fra soggetto e realtà, l’“apocalissi” evocata da Ungaretti, espongono a una crisi definitiva la possibilità della poesia di verbalizzare un mondo in erosione, devastato dalle stigmate della storia e dall’invasività di un progresso che espropria e disumanizza. E intanto una nuova cultura linguistica, estetica, filosofica, apre la poesia a un orizzonte interdisciplinare e internazionale, che spazia appunto dalle ricerche della filosofia e dell’antropologia a quelle dello strutturalismo e soprattutto della psicoanalisi, che dà voce all’inconscio come linguaggio e scopre le pulsioni dell’Es, del corporeo, mettendo allo scoperto il carattere artificiale della parola alienata dalle convenzioni. È Andrea Zanzotto, sulla scia di Lacan, a dare corpo alla lingua-materia, carne, pelle, che saltabecca in fuga verso un’oltranza, un altrove mai raggiungibile, diventando incerto frammento, “ghirigoro” mai definitivo, mai compiuto. E si stempera anche, la sua parola, nel mutismo, scoprendosi impotente di fronte all’insondabile della natura, ai suoi distanziati “silenzi”. Il plurilinguismo e il pluristilismo non sono certo estranei a questo scrivere, occupano queste parole articolate “nel morente muco”, come si impongono nella scrittura di Amelia Rosselli, realistica e visionaria, e si imporranno più avanti in quella di Jolanda Insana, la cui parola slogata in “fendenti fonici” sarcastici e furenti, ma anche disorientata sino al “martòrio”, raggiungerà i nostri giorni in un magma verbale che fagocita e aggredisce il silenzio.
Plurilinguismo, pluristilismo. Esplodono, quelle tecniche, intorno agli anni Sessanta, la stagione della neoavanguardia che fa del montaggio, dell’interferenza di registri, la propria poetica e la propria pratica di scrittura. Lo si verifica qui sui testi di Antonio Porta e Edoardo Sanguineti. In tempi segnati dall’effimero e dall’impermanenza, è soprattutto la parola del poeta di Laborintus a dissacrare ogni traccia di “poetese”, sottoponendo il verso a un intarsio di citazioni e teatralizzando l’io, di raccolta in raccolta, esponendolo in modi miniaturizzati e parodizzati, stipati nel verso insieme all’inventario di un mondo dissolto in emorragia di parole. Tra funambolismo e tragicità, il suo ribaltamento si spinge sino a cliccare, muto, il silenzio, ma senza rinunciare, neppure sui confini dell’afasia, a far vibrare il valore gestuale, fonico, materico della parola, la sua datità, la sua cosalità: una scelta di campo precisa, da parte di chi, come Sanguineti, assegna con forza alla poesia il compito di farsi coscienza critica del presente.
Il secolo breve e la mostra di Casa Moretti si chiudono su queste pronunce, che giungono a misurarsi, all’avvio del terzo millennio, con la globalizzazione sempre più invasiva che tutto ridimensiona e corrode. Impossibile dare conto delle molteplici prospettive che si aprono da qui verso le generazioni più giovani. Così, a fine percorso, se ne selezionano due sole, a rappresentarle: quella di Valerio Magrelli, con le scorciate epifanie di una parola-sguardo calcinata, cosificata, delocalizzata, e quella di Fabio Pusterla, che con tenuta ferma del ritmo misura sui residui le tracce di un comunicare sospeso. Nell’attesa che si riesca prima o poi a trasformarla assieme, la “réalité nue”, e a raccontarla, svirgolettandola. Alla prossima mostra, magari.
Niva Lorenzini
Esaurito